Renato Nicolini - Massenzio e i cinema nei Monumenti
Renato
Nicolini – Massenzio e i cinema nei Monumenti
Il nuovo decennio si caratterizzò di grandi cambiamenti: dal 1980 lo schermo cinematografico abbandonò le volte della basilica, chiusa al pubblico dopo il terremoto in Irpinia, e Nicolini colse la palla al balzo per trasformare l’Estate Romana in un grande esperimento di avanguardia architettonica per ripensare la città. Fu così che l’effimero divenne urbano.
Il nuovo sindaco Luigi Petroselli, succeduto ad Argan, stava portando avanti un’ambiziosa trasformazione: rendere l’area archeologica un grande parco libero dalle auto. A dimostrazione di questa visione, si scelse via della Consolazione, alle pendici del Campidoglio, da poche settimane chiusa al traffico; la città si sarebbe potuta così riappropriare di quello spazio finalmente strappato alle macchine.
Progettisti (scelti dallo stesso Nicolini) furono Ugo Colombari e Giuseppe De Boni, che già avevano collaborato a Parco Centrale e che da allora in avanti diventeranno gli “architetti dell’Estate Romana”. L’esperimento fu un successo ancora maggiore dei precedenti e sarà lo stesso Nicolini a dichiararsi perplesso per la decisione di Petroselli -pochi mesi più tardi- di demolire quella suggestiva via per riunire i Fori, chiedendosi “Quale sarà la sorte delle parti di città sottratte al traffico? Seguiranno quella delle zone archeologiche incomprensibili per i non specialisti, o, al più, riservate alla malinconica sfilata del turismo internazionale di massa sbarcato da giganteschi torpedoni?”.
Il nuovo sindaco Luigi Petroselli, succeduto ad Argan, stava portando avanti un’ambiziosa trasformazione: rendere l’area archeologica un grande parco libero dalle auto. A dimostrazione di questa visione, si scelse via della Consolazione, alle pendici del Campidoglio, da poche settimane chiusa al traffico; la città si sarebbe potuta così riappropriare di quello spazio finalmente strappato alle macchine.
Progettisti (scelti dallo stesso Nicolini) furono Ugo Colombari e Giuseppe De Boni, che già avevano collaborato a Parco Centrale e che da allora in avanti diventeranno gli “architetti dell’Estate Romana”. L’esperimento fu un successo ancora maggiore dei precedenti e sarà lo stesso Nicolini a dichiararsi perplesso per la decisione di Petroselli -pochi mesi più tardi- di demolire quella suggestiva via per riunire i Fori, chiedendosi “Quale sarà la sorte delle parti di città sottratte al traffico? Seguiranno quella delle zone archeologiche incomprensibili per i non specialisti, o, al più, riservate alla malinconica sfilata del turismo internazionale di massa sbarcato da giganteschi torpedoni?”.
La piazza antistante con l’Arco di Costantino, per la prima volta pedonalizzata, diventò lo scenario, senza eguali al mondo, della quinta edizione della rassegna. L’allestimento, ancora a firma De Boni e Colombari, si presentava sotto una veste particolarmente innovativa: lo schermo principale -con una platea di ben 3.500 posti- ricopriva completamente l’Arco -allora in restauro- sul lato di via San Gregorio mentre sull’altro lato fu costruita una sequenza di spazi quadrangolari che reiteravano la forma dell’antico basamento su cui troneggiava il Colosso Neroniano. Questi spazi servivano, ciascuno, per la biglietteria, il ristorante e per il bar. L’elemento che tuttavia più di tutti catturò la curiosità degli spettatori fu senz’altro l’Eidophor. gigantesche e variopinte figure fantastiche sembravamo inseguirsi sugli archi del Colosseo lasciando i romani stupefatti. Poco più in là poi un grande riflettore circolare illuminava -simbolicamente- il vuoto del selciato finalmente libero dalle macchine: questa inedita Piazza di Luce evocava la Meta Sudans, l’antica fontana romana che, non a caso, sarà poi riportata alla luce dagli scavi solo alcuni anni dopo.
In questo straordinario scenario la sera del 10 giugno si poté assistere alla visione di Napoleon con l’Orchestra di Santa Cecilia che eseguiva le musiche dal vivo e allo schermo che, nella parte finale del film, triplicava la sua grandezza con un meccanismo estensibile studiato appositamente per conferire maggiore pathos alla scena della battaglia campale.
Quando nel 1985 il Partito Comunista fu sconfitto alle elezioni amministrative arrivò il definitivo congedo dell’Estate Romana dal suo pubblico: abbandonato il centro storico, venne allestito il cinema all’aperto per l’ultima volta, tra le metafisiche architetture del ‘900. Un gesto coraggioso e per nulla convenzionale: un assessore comunista che sceglie di celebrare la città fascista.
Colombari e De Boni si trovarono questa volta a interrompere la prospettiva dechirichiana di via della Civiltà e del Lavoro dallo schermo che occludeva completamente la strada creando una nuova, straniante, chiave di lettura per quei luoghi. La sconfinata platea di fronte al Palazzo dei congressi di Libera sembrava così partecipare giocosamente -arricchendolo di nuovi significati- al monumentalismo mussoliniano dell’EUR.
Quegli allestimenti erano in realtà degli esperimenti urbani a scala reale, fatti con il lavoro congiunto
di amministrazione, sindaco, assessore, architetti e curatori, che lavorarono tutti nella stessa direzione per realizzare un’idea di città, seguiti dalla complicità di un pubblico attivo.
Otto anni, un tempo lunghissimo per quello che veniva definito, non senza disprezzo, effimero.
Edmond About, un viaggiatore francese che visitò Roma nel 1861, ha descritto (in un resoconto di viaggio, Roma contemporanea), la rivoluzione di quegli anni; il monumento mantiene la sua identità ma, sia pure per il tempo di una maratona cinematografica, accetta di sospenderla, sciogliendosi, nell’immaginario nostro contemporaneo, nei sogni ad occhi aperti che il cinema può innescare una “folla” d’individui sovrani e solitari, non la “massa” all’unisono con il delirio d’onnipotenza delle istituzioni.
Fonti sitografiche:
https://www.ilcontrafforte.com/2017/09/20/estate-romana-effimero-cultura-cambio-capitale/
https://www.ilmamilio.it/c/news/48700-massenzio-77-quando-la-cultura-riporto-la-vita-negli-anni-del-terrorismo-l-inizio-dell-estate-romana.html#:~:text=Il%2025%20Agosto%20del,'ultimo%20imperatore%20pagano%3A%20Massenzio.
http://www.instoria.it/home/estate_romana_nicolini.htm
https://www.sentieriselvaggi.it/rivista/SentieriselvaggiMagazineN.03.pdf
http://www.instoria.it/home/estate_romana_nicolini_ricordo.htm
La sera andavamo a Massenzio: quando il cinema era per tutti
Un’intervista di Massimo Piazza a Massimo Forleo
Massimo,
cosa ricordi del Massenzio 1978?
Nonostante
il tema del Medioevo non apparisse particolarmente popolare, fu un successo
inaspettato; 4/5 mila persone gremivano non solo la platea, ma tutti gli spazi
possibili, talvolta accampandosi con coperte e cuscini; una sorta di happening
di massa, dove persone di ogni provenienza si mescolavano e convivevano
pacificamente. Ricordo con particolare affetto una serata, vista ora non
facile, nella quale furono proiettati, in sequenza, “I cavalieri della Tavola
Rotonda” di Richard Thorpe, “Lancillotto e Ginevra” di Robert Bresson e Monty
Python e “Il Sagro Graal”, quasi 6 ore coi cambi pellicola, non si mosse
nessuno, se ne andarono che quasi albeggiava…”
Ma
per capire meglio, quale era l’obiettivo della programmazione?
A
quei tempi non esisteva una politica culturale; la cultura era riservata a
gruppi ristretti, ai pochi cineclub, alle sale da musica tipo Folkstudio, quasi
sempre nel centro. Separate, c’erano le sterminate periferie, e l’idea, un po’
classista, che i periferici, i coatti come diciamo a Roma, fossero condannati
all’esclusione culturale; beh, almeno in quegli anni, abbiamo dimostrato che
non era vero, e che dipendeva da come si affrontava la questione; da noi i
coatti c’erano, e ci divertivamo insieme…”.
E
dunque, come cercaste di superare questa situazione?
Il
nostro scopo era rompere queste barriere, coinvolgere le periferie con eventi
che non fossero escludenti; nella serata di cui ho parlato, ad esempio,
inserimmo il film difficile in mezzo a due più facili; così 5.000 persone
videro Bresson, la maggior parte, credo, per la prima volta. Ricercavamo un
equilibrio, non facile, tra la qualità della proposta e la necessità, la voglia
direi, di contaminare generi e pubblici, di non escludere nessuno”.
Com’era
quella estate del 1979, che clima si respirava?
Erano
ancora anni difficili: il ’79 era l’anno dell’arresto dei leader di Potere
operaio e Autonomia operaia Oreste Scalzone, Toni Negri e Franco Piperno; era
anche l’anno dell’omicidio di Giorgio Ambrosoli il liquidatore della banca di
Sindona; a Palermo veniva ucciso dalla mafia il commissario Boris Giuliano; si
formava il primo governo “Kossiga”, come fu battezzato dalla estrema sinistra.
Ma tra la gente c’era voglia di vivere, di uscire, di rompere l’assedio della
paura, e Massenzio era ormai un mito.
Ti
occupasti della programmazione di settembre denominata Prometeo; come fu
concepita?
Se non sbaglio, faceste un grande colpo con un mito del calcio…
Beh, in quel caso facemmo davvero un gran colpo. Eravamo ragazzi nati intorno agli anni ’50, e tutti avevamo nella testa la prima diretta televisiva vincente, dopo la sconfitta con la Corea nel 1966: i Mondiali Messico ’70, Italia-Germania 4-3. A quei tempi non c’era internet né le tante tv, e nessuno aveva più visto quella partita; cercai inutilmente la copia, finché un usciere della Fgci di Roma mi disse che il mitico dottor Fini, medico degli azzurri, ne aveva una copia che utilizzava per gli stage; andai a Coverciano, e ricevetti da lui una pizza in bianco e nero, che fu custodita per tutto il tempo da un suo addetto, per dire quanto era preziosa.
E
come andò?
All’apertura
del botteghino c’era una fila mostruosa; arrivati a 5.000 spettatori, i vigili
intimarono la chiusura: quelli restati fuori premevano, ricordo uno che diceva
“vengo da Frosinone”, un altro “da Firenze” e tutti “entriamo o con le buone o
con le cattive”. Momenti difficili, alla fine tutto andò bene, erano tempi
fantastici. Riuscii a tenerli tutti intrattenendoli con “Nashville” di Robert
Altman, oltre 3 ore con cori bandiere e trombe. Passando dal 35 mm. al 16 mm.,
mandammo “Mexico e Nuvole” di Jannaci e poi partì la pellicola: un boato
indimenticabile, una festa.
Altri
aneddoti?
Dovete
pensare che al tempo eravamo ragazzi di 25 anni, alle prime esperienze; una
sera con tema “Il mostro” in cui programmavamo “Psyko” di Alfred Hitchcock, “Il
collezionista” di William Wyler e “L’inquilino del III piano”, non so se mi
spiego, alla cassa si presentano Isabella Rossellini e Martin Scorsese e
chiedono due biglietti; era troppo, tutto doveva essere un sogno, e Massenzio
dei primi anni era davvero un sogno.
E siccome tutti i sogni finiscono all’alba, come finì?
Il 19 settembre, durante la proiezione di “West Side Story”, a Roma fu avvertita una scossa di terremoto; in sala non fu percepita, ma in via dei Fori Imperiali gli sfollati dalle case si incontrarono con gli spettatori, le due maree si fusero e sciolsero la tensione. La scossa però lesionò la volta della Basilica, che così non poté più ospitarci. Il cinema si trasferì al Colosseo, con il super evento della proiezione di “Napoleon” di Abel Gance su tre schermi e l’orchestra diretta dal padre di Coppola, poi a Circo Massimo e altre location; ma l’incanto era finito, e pian piano una eccessiva commercializzazione portò al declino della manifestazione.
Cosa
resta di questa esperienza?
La
consapevolezza che il cinema è amato dalla gente, che il buon cinema può essere
per tutti e non solo per le élites; a Massenzio, forse, dobbiamo i mille
schermi di cinema che ogni estate illuminano le nostre città…
https://www.periscopionline.it/le-luci-di-massenzio-fra-le-ombre-dello-stragismo-39563.html















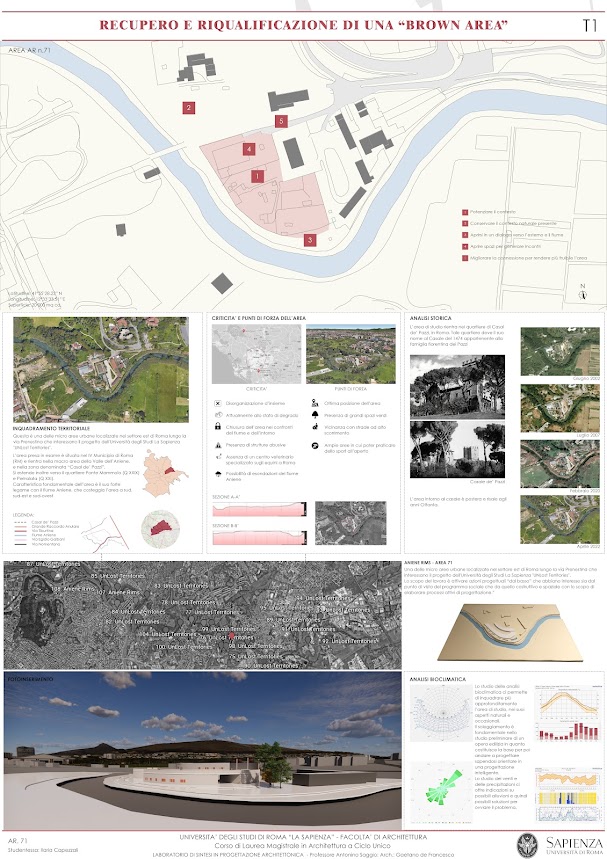
Commenti
Posta un commento